Sala I - Preistoria di Este e dei Colli Euganei  Questa sala, al piano nobile del palazzo, è dedicata alle raccolte preistoriche. Manufatti in selce testimoniano la più antica frequentazione del versante occidentale dei Colli Euganei durante il Paleolitico, mentre nel Mesolitico la presenza umana si attesta in località Valcalaona (Baone) e Malandrina (Lozzo Atestino). Notevoli sono le testimonianze per il Neolitico. Ai nuclei da Le Basse di Valcalaona del Neolitico antico (Cultura di Fiorano) e recente (Cultura dei vasi a bocca quadrata, stile a “incisioni e impressioni”) seguono quelli del Neolitico medio di Maserà. Nella stessa grande vetrina sono esposti pure i materiali dell’abitato di Castelnuovo di Teolo riferibili agli aspetti finali della Cultura dei vasi a bocca quadrata e all’età del Rame. L’Eneolitico viene esemplificato da singoli reperti da Este e da manufatti ceramici d’abitato da Este-località Meggiaro. La fase di transizione tra età del Rame ed età del Bronzo è documentata dal vasellame ceramico domestico da Este-Ca’ Mori.
Per l’antica e media età del Bronzo si segnala il copioso materiale dall’insediamento perilacustre del Laghetto della Costa presso Arquà Petrarca. Esemplificano l’età del Bronzo recente i materiali dagli abitati di Marendole (Monselice) e di Lozzo Atestino. Assai varia (ceramica, bronzi, manufatti litici) è la documentazione dai siti arginati di Casale di Scodosia-località Vallerana e Montagnana-Borgo S. Zeno, contraddistinti da aspetti culturali terramaricoli e della Cultura subappenninica. Segue l’esposizione dei due ripostigli di bronzi da Merlara e di Lozzo Atestino, databili rispettivamente al Bronzo recente (XIII sec. a.C.) e a una fase di transizione al Bronzo finale (XII sec. a.C.). Il percorso di visita si conclude con l’esposizione di manufatti in bronzo dal centro di Este. Questa sala, al piano nobile del palazzo, è dedicata alle raccolte preistoriche. Manufatti in selce testimoniano la più antica frequentazione del versante occidentale dei Colli Euganei durante il Paleolitico, mentre nel Mesolitico la presenza umana si attesta in località Valcalaona (Baone) e Malandrina (Lozzo Atestino). Notevoli sono le testimonianze per il Neolitico. Ai nuclei da Le Basse di Valcalaona del Neolitico antico (Cultura di Fiorano) e recente (Cultura dei vasi a bocca quadrata, stile a “incisioni e impressioni”) seguono quelli del Neolitico medio di Maserà. Nella stessa grande vetrina sono esposti pure i materiali dell’abitato di Castelnuovo di Teolo riferibili agli aspetti finali della Cultura dei vasi a bocca quadrata e all’età del Rame. L’Eneolitico viene esemplificato da singoli reperti da Este e da manufatti ceramici d’abitato da Este-località Meggiaro. La fase di transizione tra età del Rame ed età del Bronzo è documentata dal vasellame ceramico domestico da Este-Ca’ Mori.
Per l’antica e media età del Bronzo si segnala il copioso materiale dall’insediamento perilacustre del Laghetto della Costa presso Arquà Petrarca. Esemplificano l’età del Bronzo recente i materiali dagli abitati di Marendole (Monselice) e di Lozzo Atestino. Assai varia (ceramica, bronzi, manufatti litici) è la documentazione dai siti arginati di Casale di Scodosia-località Vallerana e Montagnana-Borgo S. Zeno, contraddistinti da aspetti culturali terramaricoli e della Cultura subappenninica. Segue l’esposizione dei due ripostigli di bronzi da Merlara e di Lozzo Atestino, databili rispettivamente al Bronzo recente (XIII sec. a.C.) e a una fase di transizione al Bronzo finale (XII sec. a.C.). Il percorso di visita si conclude con l’esposizione di manufatti in bronzo dal centro di Este. |
Sala II - Gli abitati protostorici ad Este e nell’agro atestino  In questa sala sono esposti manufatti provenienti dall’antico centro veneto di Este e di altri insediamenti coevi sorti nell’agro atestino. L’abitato di Este-Borgo Canevedo, sorto nel Bronzo finale (XI-X sec. a.C.) in prossimità dell’antico corso dell’Adige, è documentato da vasellame di uso domestico (piatti, scodelle, tazze, olle, vasi biconici, ecc.), da manufatti in osso o corno (zappette, pettine, immanicature) e da oggetti in bronzo. Sono da riferire alle attività femminili della filatura e della tessitura le fusaiole e i pesi da telaio. Alla sfera ideologica va collegata verosimilmente la produzione plastica di piccoli animali (cavallini e bovidi).
Uno spaccato di vita del centro veneto di Este tra VIII e IV sec. a.C. viene fornito dai materiali delle abitazioni di Este-via Restara: vasellame da mensa e da cucina, fusaiole e rocchetti per l’attività tessile; piccole macine in trachite per la molitura, ecc. L’attività metallurgica è attestata principalmente da una valva di fusione in ardesia per pendagli. Da una casa laboratorio di via Restara proviene il piano di lavoro in terracotta esposto a livello del pavimento.
Da aree diverse del centro di Este provengono bracieri e frammenti di alari in terracotta con parti terminali a testa di ariete. Il fiorente artigianato ceramico locale è rappresentato da vasi, anche di grandi dimensioni, con la caratteristica decorazione a fasce rosse e nere e a stralucido, mentre i numerosi frammenti di ceramica attica provano gli scambi commerciali con l’area adriatica (Spina e Adria).
La vita dei centri della bassa pianura padovana, tra XI e IX sec. a.C. viene esemplificata da un significativa documentazione di vasellame fittile e oggetti in osso-corno e bronzo provenienti dal grande abitato di Montagnana-Borgo San Zeno. Il ruolo assunto da questo centro con l’area adriatica attraverso il corso dell’Adige e, più in generale, con il Mediterraneo orientale, è testimoniato da un frammento di vaso di ceramica d’importazione da un centro miceneo e da una piccola spirale in oro. Gli abitati veneti del territorio atestino sono esemplificati dall’abitato di Megliadino San Fidenzio, località Spin, di cui è esposta una significativa campionatura di vasellame ceramico di uso domestico. In questa sala sono esposti manufatti provenienti dall’antico centro veneto di Este e di altri insediamenti coevi sorti nell’agro atestino. L’abitato di Este-Borgo Canevedo, sorto nel Bronzo finale (XI-X sec. a.C.) in prossimità dell’antico corso dell’Adige, è documentato da vasellame di uso domestico (piatti, scodelle, tazze, olle, vasi biconici, ecc.), da manufatti in osso o corno (zappette, pettine, immanicature) e da oggetti in bronzo. Sono da riferire alle attività femminili della filatura e della tessitura le fusaiole e i pesi da telaio. Alla sfera ideologica va collegata verosimilmente la produzione plastica di piccoli animali (cavallini e bovidi).
Uno spaccato di vita del centro veneto di Este tra VIII e IV sec. a.C. viene fornito dai materiali delle abitazioni di Este-via Restara: vasellame da mensa e da cucina, fusaiole e rocchetti per l’attività tessile; piccole macine in trachite per la molitura, ecc. L’attività metallurgica è attestata principalmente da una valva di fusione in ardesia per pendagli. Da una casa laboratorio di via Restara proviene il piano di lavoro in terracotta esposto a livello del pavimento.
Da aree diverse del centro di Este provengono bracieri e frammenti di alari in terracotta con parti terminali a testa di ariete. Il fiorente artigianato ceramico locale è rappresentato da vasi, anche di grandi dimensioni, con la caratteristica decorazione a fasce rosse e nere e a stralucido, mentre i numerosi frammenti di ceramica attica provano gli scambi commerciali con l’area adriatica (Spina e Adria).
La vita dei centri della bassa pianura padovana, tra XI e IX sec. a.C. viene esemplificata da un significativa documentazione di vasellame fittile e oggetti in osso-corno e bronzo provenienti dal grande abitato di Montagnana-Borgo San Zeno. Il ruolo assunto da questo centro con l’area adriatica attraverso il corso dell’Adige e, più in generale, con il Mediterraneo orientale, è testimoniato da un frammento di vaso di ceramica d’importazione da un centro miceneo e da una piccola spirale in oro. Gli abitati veneti del territorio atestino sono esemplificati dall’abitato di Megliadino San Fidenzio, località Spin, di cui è esposta una significativa campionatura di vasellame ceramico di uso domestico. |
Sala III - Le necropoli dell’età del Ferro  In questa sala sono esposti corredi tombali e serie tipologiche di oggetti provenienti dalle ricche necropoli atestine ad incinerazione (X-III sec. a.C.), queste ultime indicate con i nomi dei proprietari dei fondi in cui sono state rinvenute.
Tra le tombe più antiche (X-IX sec. a.C.), costituite dal vaso ossuario con scodella di copertura e da un semplice corredo per lo più in bronzo, si segnalano quelle da Prà d’Este e da Este-fondo Pelà, da dove proviene il noto vaso a forma di palmipede su ruote. Tra l'VIII e il VII sec. a.C., con l’affermarsi della Cultura dei Veneti antichi, il rito funerario diviene più complesso e i corredi diversificati in base al sesso del defunto. Dalla metà dell’VIII sec. a.C. l’emergere di spiccate differenze sociali ed economiche si riflette anche nella ricchezza e complessità dei corredi funerari. In questo periodo ha inizio pure una produzione ceramica fine per uso funerario e si diffonde contemporaneamente l’uso del ferro.
Dalla fine del VII sec. a.C., come anticipato dai motivi riprodotti su una tazza in lamina di bronzo della tomba Benvenuti 122, accanto alla decorazione a sbalzo o a incisione con motivi geometrici, compare quella a figure di animali di tipo orientalizzante. Alla fine dello stesso secolo si sviluppa a Este, forse a seguito dell’arrivo di bronzisti (da Bologna?), una produzione di bronzi in lamina nota come “arte delle situle”, il cui capolavoro indiscusso è la situla della tomba femminile Benvenuti 126, datata attorno al 600 a.C.
Tra VI e IV sec. a.C. predomina il vasellame con decorazione a fasce rosse e nere, spesso con motivi impressi a stampo; le tipologie ricorrenti sono i vasi situliformi, i bicchieri e le coppe; tra gli oggetti dell’abbigliamento prevalgono le fibule del tipo ad arco serpeggiante, a drago, a navicella, a sanguisuga. Dalla fine del VI sec. a.C. è presente la fibula “tipo Certosa”, così denominata dalla necropoli della Certosa presso Bologna. Si datano alla seconda metà del IV sec. a.C. le note tombe Boldù Dolfin nn. 52-53, la cui scoperta nel 1876 segnò l’inizio dell’esplorazione delle necropoli protostoriche.
Contatti con la cultura celtica, dovuti a scambi commerciali, ma anche a una penetrazione etnica anche se non di particolare consistenza, sono attestati, ad esempio, nei corredi funerari della tomba Ricovero 226 (orecchini d’argento), della tomba Benvenuti 116 (gancio di cintura in ferro traforato), della tomba Benvenuti 123 a più deposizioni (fibule in bronzo tipo La Tène, armille in bronzo e in pasta di vetro, spada in ferro ripiegata ritualmente).
Sulla parete di fondo della sala è esposta una serie di cippi funerari in trachite con iscrizioni in lingua venetica databili tra VI e IV sec. a.C. In questa sala sono esposti corredi tombali e serie tipologiche di oggetti provenienti dalle ricche necropoli atestine ad incinerazione (X-III sec. a.C.), queste ultime indicate con i nomi dei proprietari dei fondi in cui sono state rinvenute.
Tra le tombe più antiche (X-IX sec. a.C.), costituite dal vaso ossuario con scodella di copertura e da un semplice corredo per lo più in bronzo, si segnalano quelle da Prà d’Este e da Este-fondo Pelà, da dove proviene il noto vaso a forma di palmipede su ruote. Tra l'VIII e il VII sec. a.C., con l’affermarsi della Cultura dei Veneti antichi, il rito funerario diviene più complesso e i corredi diversificati in base al sesso del defunto. Dalla metà dell’VIII sec. a.C. l’emergere di spiccate differenze sociali ed economiche si riflette anche nella ricchezza e complessità dei corredi funerari. In questo periodo ha inizio pure una produzione ceramica fine per uso funerario e si diffonde contemporaneamente l’uso del ferro.
Dalla fine del VII sec. a.C., come anticipato dai motivi riprodotti su una tazza in lamina di bronzo della tomba Benvenuti 122, accanto alla decorazione a sbalzo o a incisione con motivi geometrici, compare quella a figure di animali di tipo orientalizzante. Alla fine dello stesso secolo si sviluppa a Este, forse a seguito dell’arrivo di bronzisti (da Bologna?), una produzione di bronzi in lamina nota come “arte delle situle”, il cui capolavoro indiscusso è la situla della tomba femminile Benvenuti 126, datata attorno al 600 a.C.
Tra VI e IV sec. a.C. predomina il vasellame con decorazione a fasce rosse e nere, spesso con motivi impressi a stampo; le tipologie ricorrenti sono i vasi situliformi, i bicchieri e le coppe; tra gli oggetti dell’abbigliamento prevalgono le fibule del tipo ad arco serpeggiante, a drago, a navicella, a sanguisuga. Dalla fine del VI sec. a.C. è presente la fibula “tipo Certosa”, così denominata dalla necropoli della Certosa presso Bologna. Si datano alla seconda metà del IV sec. a.C. le note tombe Boldù Dolfin nn. 52-53, la cui scoperta nel 1876 segnò l’inizio dell’esplorazione delle necropoli protostoriche.
Contatti con la cultura celtica, dovuti a scambi commerciali, ma anche a una penetrazione etnica anche se non di particolare consistenza, sono attestati, ad esempio, nei corredi funerari della tomba Ricovero 226 (orecchini d’argento), della tomba Benvenuti 116 (gancio di cintura in ferro traforato), della tomba Benvenuti 123 a più deposizioni (fibule in bronzo tipo La Tène, armille in bronzo e in pasta di vetro, spada in ferro ripiegata ritualmente).
Sulla parete di fondo della sala è esposta una serie di cippi funerari in trachite con iscrizioni in lingua venetica databili tra VI e IV sec. a.C. |
Sala IV - Luoghi di culto e stipi votive dell’età del Ferro  La sala raccoglie le testimonianze provenienti dai diversi luoghi di culto di Este. Il più importante fu sicuramente quello dedicato alla dea Reitia, sorto presso l’antico corso dell’Adige, nel fondo Baratella, e frequentato dalla fine del VII sec. a.C. al II sec. d.C. Tra gli ex voto numerosissimi sono i bronzetti raffiguranti devoti, guerrieri o divinità; quelli anatomici legati al carattere “sanante” della divinità, le lamine votive in bronzo (con rappresentazioni a sbalzo o a stampo). Da riferire alle libagioni sono coppe e vasi miniaturistici; alle attività femminili della filatura e tessitura le fusaiole, i rocchetti e i pesi da telaio. Le “tavolette alfabetiche” e gli stili scrittori testimoniano dell’esistenza presso il santuario di un centro di insegnamento della scrittura. Della fase romana tardo-repubblicana del santuario sono pervenuti alcuni frammenti architettonici (colonne, capitelli, cornici) ed elementi in terracotta.
Un secondo nucleo di reperti, databili dal V sec. a.C. all’età romana, proviene dal luogo di culto individuato in località Caldevigo di cui si segnala la cosiddetta “dea di Caldevigo” rappresentante una donna con il tipico abbigliamento locale (cinturone a losanga e alti stivali) e adorna di ricche collane e bracciali. Della stipe votiva, rinvenuta in località Morlungo, si segnalano gli ex voto bronzei riproducenti organi sessuali maschili e femminili dedicati a una divinità protettrice della fecondità. La sala raccoglie le testimonianze provenienti dai diversi luoghi di culto di Este. Il più importante fu sicuramente quello dedicato alla dea Reitia, sorto presso l’antico corso dell’Adige, nel fondo Baratella, e frequentato dalla fine del VII sec. a.C. al II sec. d.C. Tra gli ex voto numerosissimi sono i bronzetti raffiguranti devoti, guerrieri o divinità; quelli anatomici legati al carattere “sanante” della divinità, le lamine votive in bronzo (con rappresentazioni a sbalzo o a stampo). Da riferire alle libagioni sono coppe e vasi miniaturistici; alle attività femminili della filatura e tessitura le fusaiole, i rocchetti e i pesi da telaio. Le “tavolette alfabetiche” e gli stili scrittori testimoniano dell’esistenza presso il santuario di un centro di insegnamento della scrittura. Della fase romana tardo-repubblicana del santuario sono pervenuti alcuni frammenti architettonici (colonne, capitelli, cornici) ed elementi in terracotta.
Un secondo nucleo di reperti, databili dal V sec. a.C. all’età romana, proviene dal luogo di culto individuato in località Caldevigo di cui si segnala la cosiddetta “dea di Caldevigo” rappresentante una donna con il tipico abbigliamento locale (cinturone a losanga e alti stivali) e adorna di ricche collane e bracciali. Della stipe votiva, rinvenuta in località Morlungo, si segnalano gli ex voto bronzei riproducenti organi sessuali maschili e femminili dedicati a una divinità protettrice della fecondità. |
Sala V - Le necropoli del territorio atestino  Questa sala, sottoposta a recenti interventi di restauro, è dedicata alle testimonianze funerarie dal territorio atestino.
Il nucleo più antico è rappresentato dai corredi delle tombe a incinerazione da Montagnana - Borgo S. Zeno del Bronzo finale-prima età del Ferro (X-VIII sec. a.C.). Di particolare interesse è la sepoltura a inumazione di donna con feto, ornata, al momento della deposizione, da due fermatrecce in bronzo.
Alla piena età del ferro, tra VII e V sec. a C., si datano le tombe ad incinerazione da Saletto-Fondo Besola, tra le quali spicca una sepoltura femminile con vari oggetti di ornamento tra cui una collana in perle d’ambra.
Le tombe a incinerazione da Arquà Petrarca, attestano, con i loro corredi, il persistere della tradizione locale, ma anche dei nuovi influssi provenienti dal mondo celtico e dal mondo romano. Questa sala, sottoposta a recenti interventi di restauro, è dedicata alle testimonianze funerarie dal territorio atestino.
Il nucleo più antico è rappresentato dai corredi delle tombe a incinerazione da Montagnana - Borgo S. Zeno del Bronzo finale-prima età del Ferro (X-VIII sec. a.C.). Di particolare interesse è la sepoltura a inumazione di donna con feto, ornata, al momento della deposizione, da due fermatrecce in bronzo.
Alla piena età del ferro, tra VII e V sec. a C., si datano le tombe ad incinerazione da Saletto-Fondo Besola, tra le quali spicca una sepoltura femminile con vari oggetti di ornamento tra cui una collana in perle d’ambra.
Le tombe a incinerazione da Arquà Petrarca, attestano, con i loro corredi, il persistere della tradizione locale, ma anche dei nuovi influssi provenienti dal mondo celtico e dal mondo romano. |
Sala VI - La romanizzazione di Este  In questa sala è esposta, fuori contesto cronologico per motivi statici, la tomba monumentale “Casa di Ricovero 23”, databile alla prima metà del III sec. a.C., la cui tipologia oscilla fra il sarcofago e la tomba a camera di modello etrusco.
Il notevole rango della defunta è indicato, oltre che dal ricco corredo funerario, anche dal nome, Nerka Trostiaia, inciso sull’orlo della situla bronzea.
I restanti materiali della sala illustrano la fase di trapasso della Civiltà dei Veneti antichi a quella romana. I cippi confinari di Galzignano e del Monte Venda (141 a.C. o 116 a.C.) sono testimonianza dell’intervento del Senato di Roma per regolamentare i confini tra Atestini e Patavini. Altro importante documento è la tabula Atestina (o Fragmentum Atestinum), legge dei primi decenni del I sec. a.C. incisa su una lastra di bronzo pervenutaci mutila, che riguarda le competenze dei magistrati locali nell’ambito della Gallia Cisalpina.
Il passaggio dalla lingua venetica al latino è documentato da lapidi funerarie, nonché da numerose iscrizioni incise sui vasi ossuari, come nel caso della tomba della famiglia dei Titinii. In questa sala è esposta, fuori contesto cronologico per motivi statici, la tomba monumentale “Casa di Ricovero 23”, databile alla prima metà del III sec. a.C., la cui tipologia oscilla fra il sarcofago e la tomba a camera di modello etrusco.
Il notevole rango della defunta è indicato, oltre che dal ricco corredo funerario, anche dal nome, Nerka Trostiaia, inciso sull’orlo della situla bronzea.
I restanti materiali della sala illustrano la fase di trapasso della Civiltà dei Veneti antichi a quella romana. I cippi confinari di Galzignano e del Monte Venda (141 a.C. o 116 a.C.) sono testimonianza dell’intervento del Senato di Roma per regolamentare i confini tra Atestini e Patavini. Altro importante documento è la tabula Atestina (o Fragmentum Atestinum), legge dei primi decenni del I sec. a.C. incisa su una lastra di bronzo pervenutaci mutila, che riguarda le competenze dei magistrati locali nell’ambito della Gallia Cisalpina.
Il passaggio dalla lingua venetica al latino è documentato da lapidi funerarie, nonché da numerose iscrizioni incise sui vasi ossuari, come nel caso della tomba della famiglia dei Titinii. |
Sala VII - La vita pubblica a Este in età romana  Iscrizioni e rilievi di varia natura forniscono indicazioni preziose sulla pubblica amministrazione e sulle divinità onorate ad Ateste.
Sulla parete di fondo è stato ricostruito il fregio fittile (composto da triglifi e metope), che decorava la facciata di un tempio dedicato a una coppia divina, probabilmente i Dioscuri. Il tempio sorgeva nella zona attualmente denominata Casale, dove anticamente scorreva l’Adige. Alla più antica fase del santuario, ancora nell’età del Ferro, va riferita la piccola coppa bronzea con iscrizione venetica. Gli oggetti della stipe del tempio romano, costituiti principalmente da manufatti metallici, documentano fino al II sec. d.C. l’attività del santuario, le cui divinità presiedevano alla navigazione, al commercio, alla pesca, ma anche alla salute e alla fertilità. Un altro aspetto della vita pubblica romana è documentato dall’esposizione di monete romane di età repubblicana e imperiale, di cui si segnala il raro medaglione aureo, emissione augustea del 2 a.C. Iscrizioni e rilievi di varia natura forniscono indicazioni preziose sulla pubblica amministrazione e sulle divinità onorate ad Ateste.
Sulla parete di fondo è stato ricostruito il fregio fittile (composto da triglifi e metope), che decorava la facciata di un tempio dedicato a una coppia divina, probabilmente i Dioscuri. Il tempio sorgeva nella zona attualmente denominata Casale, dove anticamente scorreva l’Adige. Alla più antica fase del santuario, ancora nell’età del Ferro, va riferita la piccola coppa bronzea con iscrizione venetica. Gli oggetti della stipe del tempio romano, costituiti principalmente da manufatti metallici, documentano fino al II sec. d.C. l’attività del santuario, le cui divinità presiedevano alla navigazione, al commercio, alla pesca, ma anche alla salute e alla fertilità. Un altro aspetto della vita pubblica romana è documentato dall’esposizione di monete romane di età repubblicana e imperiale, di cui si segnala il raro medaglione aureo, emissione augustea del 2 a.C. |
Sala VIII - Le necropoli romane di Este  Le necropoli romane abbracciano un arco cronologico che va dall’età augustea al II sec. d.C.; il rito maggiormente rappresentato è quello dell’incinerazione, che fu praticato almeno fino agli inizi del II sec. d.C. quando, per mutate concezioni religiose, si impose il rito dell’inumazione.
In questa sala è stato ricomposto un piccolo sepolcreto del I sec. d.C. rinvenuto nella proprietà Rebato, destinato a schiavi e liberti di grandi famiglie, tra cui la gens Arria; nel primo recinto il cippo fungeva da ara per i sacrifici; nel secondo erano state poste l50 sepolture, di cui alcune anche monumentali. Oltre ai consueti oggetti del corredo funerario si segnala una lamina in piombo con incisa una maledizione (defixio).
Segue un’ampia rassegna di monumenti rinvenuti ad Este e nell’agro, suddivisi per tipologia: cippi a lastra, a edicola, “ad ara”; sarcofagi, ecc. Tra i corredi funerari, esposti nelle vetrine, di particolare interesse è quello di un medico (tomba Capodoglio IX) che presenta gli strumenti del mestiere (bisturi, nettaorecchie, sonde, pinzette, ecc.).
Di probabile pertinenza funeraria è pure la statua di personaggio togato da Prà d’Este, posta sulla parete di fondo della sala. Le necropoli romane abbracciano un arco cronologico che va dall’età augustea al II sec. d.C.; il rito maggiormente rappresentato è quello dell’incinerazione, che fu praticato almeno fino agli inizi del II sec. d.C. quando, per mutate concezioni religiose, si impose il rito dell’inumazione.
In questa sala è stato ricomposto un piccolo sepolcreto del I sec. d.C. rinvenuto nella proprietà Rebato, destinato a schiavi e liberti di grandi famiglie, tra cui la gens Arria; nel primo recinto il cippo fungeva da ara per i sacrifici; nel secondo erano state poste l50 sepolture, di cui alcune anche monumentali. Oltre ai consueti oggetti del corredo funerario si segnala una lamina in piombo con incisa una maledizione (defixio).
Segue un’ampia rassegna di monumenti rinvenuti ad Este e nell’agro, suddivisi per tipologia: cippi a lastra, a edicola, “ad ara”; sarcofagi, ecc. Tra i corredi funerari, esposti nelle vetrine, di particolare interesse è quello di un medico (tomba Capodoglio IX) che presenta gli strumenti del mestiere (bisturi, nettaorecchie, sonde, pinzette, ecc.).
Di probabile pertinenza funeraria è pure la statua di personaggio togato da Prà d’Este, posta sulla parete di fondo della sala. |
Sala IX - Arti e mestieri; la vita quotidiana a Este in età romana  Arti e mestieri sono rappresentati sui monumenti, per lo più funerari, esposti nella zona tra le finestre della sala. Fra gli artigiani vi sono un calderaio, un calzolaio, due cardatori di lana, un cuoco; tra i professionisti un medico e un militare. Le anfore rinvenute a Este e dintorni documentano consumi di generi alimentari sia prodotti nella regione che importati: le forme attestano importazioni dall’Istria, dall’Italia meridionale (vino), dalla Spagna (olio e salsa di pesce) nel I sec. d.C., e dall’Africa nel II sec. d.C. I materiali esposti nelle vetrine illustrano la casa, sia come struttura architettonica che come luogo di attività domestiche e artigianali; vi sono tegole, elementi di decorazione architettonica, stucchi parietali, serrature e chiavi, ma anche parti di candelabri e lucerne. Le attività domestiche sono documentate anche da stoviglie da cucina e da mensa, nonché da posateria in bronzo; pesi da telaio, rocchetti e fusaiole fittili richiamano una fiorente attività di filatura e tessitura.
Uno spaccato di vita, dall’età preromana all’età romana, viene fornito da una significativa campionatura di materiale rinvenuto nello scavo di un quartiere dell’antico centro di Este, nell’area dell’Ospedale Civile. Arti e mestieri sono rappresentati sui monumenti, per lo più funerari, esposti nella zona tra le finestre della sala. Fra gli artigiani vi sono un calderaio, un calzolaio, due cardatori di lana, un cuoco; tra i professionisti un medico e un militare. Le anfore rinvenute a Este e dintorni documentano consumi di generi alimentari sia prodotti nella regione che importati: le forme attestano importazioni dall’Istria, dall’Italia meridionale (vino), dalla Spagna (olio e salsa di pesce) nel I sec. d.C., e dall’Africa nel II sec. d.C. I materiali esposti nelle vetrine illustrano la casa, sia come struttura architettonica che come luogo di attività domestiche e artigianali; vi sono tegole, elementi di decorazione architettonica, stucchi parietali, serrature e chiavi, ma anche parti di candelabri e lucerne. Le attività domestiche sono documentate anche da stoviglie da cucina e da mensa, nonché da posateria in bronzo; pesi da telaio, rocchetti e fusaiole fittili richiamano una fiorente attività di filatura e tessitura.
Uno spaccato di vita, dall’età preromana all’età romana, viene fornito da una significativa campionatura di materiale rinvenuto nello scavo di un quartiere dell’antico centro di Este, nell’area dell’Ospedale Civile. |
Sala X - La vita privata a Este in età romana  Continua dalla sala precedente l’esposizione di oggetti legati alla vita privata nei suoi aspetti più personali (oggetti d’ornamento, strumenti da toilette, balsamari in vetro e in terracotta). Tra gli oggetti di uso domestico si segnala una buona campionatura di vasellame fine da mensa in terracotta, bronzo e vetro. A un artigianato locale sono da riferire una serie di bronzetti raffiguranti principalmente divinità femminili (Iside-Fortuna, Minerva, Venere, Diana, ecc.).
Provengono dal centro di Abano Terme, anche se non è noto il contesto di rinvenimento, un gruppo di vasi potori in ceramica invetriata a forma di corno configurati nella parte terminale a protome equina.
Il manufatto più notevole è senz’altro il grande frammento di soffitto affrescato ricostruito e collocato in questa sala all’incirca all’altezza originaria. Esso era pertinente a una vasta sala di rappresentanza (m 14,60X 7,85) della lussuosa domus romana messa in luce nel 1937 nell’area del Serraglio Albrizzi di Este.
Il cromatismo predominante (giallo-ocra, rosso scuro, nero ed azzurro) e l’uso di precipui elementi decorativi consentono di datare l’affresco ad età adrianea. Continua dalla sala precedente l’esposizione di oggetti legati alla vita privata nei suoi aspetti più personali (oggetti d’ornamento, strumenti da toilette, balsamari in vetro e in terracotta). Tra gli oggetti di uso domestico si segnala una buona campionatura di vasellame fine da mensa in terracotta, bronzo e vetro. A un artigianato locale sono da riferire una serie di bronzetti raffiguranti principalmente divinità femminili (Iside-Fortuna, Minerva, Venere, Diana, ecc.).
Provengono dal centro di Abano Terme, anche se non è noto il contesto di rinvenimento, un gruppo di vasi potori in ceramica invetriata a forma di corno configurati nella parte terminale a protome equina.
Il manufatto più notevole è senz’altro il grande frammento di soffitto affrescato ricostruito e collocato in questa sala all’incirca all’altezza originaria. Esso era pertinente a una vasta sala di rappresentanza (m 14,60X 7,85) della lussuosa domus romana messa in luce nel 1937 nell’area del Serraglio Albrizzi di Este.
Il cromatismo predominante (giallo-ocra, rosso scuro, nero ed azzurro) e l’uso di precipui elementi decorativi consentono di datare l’affresco ad età adrianea. |
Sala XI - Monumenti medievali e rinascimentali; ceramiche (XIII-XIX secolo)  Questa sala, al pianoterra, conclude il percorso di visita; qui sono esposti frammenti architettonici ed arredi provenienti da chiese ed edifici per lo più dismessi o demoliti, di Este e dintorni. Degni di nota sono un pluteo decorato con il motivo cristiano dei pavoni (VIII secolo), una Pietà lignea di scuola tedesca (XIV secolo), ma soprattutto la tavola raffigurante una Madonna con il Bambino di Giovan Battista Cima da Conegliano, eseguita nel 1504 per il Convento di Santa Maria delle Consolazioni di Este.
Nella vetrina a nastro sulla destra trova posto un’ampia selezione di generi ceramici commerciati o prodotti nel territorio di Este tra il XIII e il XIX secolo. Il nucleo più omogeneo è costituito da una serie di maioliche berrettine e compendiarie venete e faentine prodotte tra 1579 e 1600.
Per la produzione ceramica atestina segnaliamo i prodotti della manifattura Franchini di fine Settecento e della manifattura Brunello, poi Contiero della seconda metà del Settecento e primi decenni dell’Ottocento. Questa sala, al pianoterra, conclude il percorso di visita; qui sono esposti frammenti architettonici ed arredi provenienti da chiese ed edifici per lo più dismessi o demoliti, di Este e dintorni. Degni di nota sono un pluteo decorato con il motivo cristiano dei pavoni (VIII secolo), una Pietà lignea di scuola tedesca (XIV secolo), ma soprattutto la tavola raffigurante una Madonna con il Bambino di Giovan Battista Cima da Conegliano, eseguita nel 1504 per il Convento di Santa Maria delle Consolazioni di Este.
Nella vetrina a nastro sulla destra trova posto un’ampia selezione di generi ceramici commerciati o prodotti nel territorio di Este tra il XIII e il XIX secolo. Il nucleo più omogeneo è costituito da una serie di maioliche berrettine e compendiarie venete e faentine prodotte tra 1579 e 1600.
Per la produzione ceramica atestina segnaliamo i prodotti della manifattura Franchini di fine Settecento e della manifattura Brunello, poi Contiero della seconda metà del Settecento e primi decenni dell’Ottocento. |
| Prosdocimi A., Brevi cenni del Museo Nazionale Atestino in Este: ex Museo Civico, Este 1902. |
| Callegari A., Il Museo Nazionale Atestino in Este, Roma 1937. |
| Fogolari G., Il Museo Nazionale Atestino in Este, Roma 1957. |
| Fogolari G., Prosdocimi A.L., I Veneti antichi. Lingua e cultura, Padova 1988. |
| Capuis L., I Veneti. Società e cultura di un popolo dell’Italia preromana, Milano 1993. |
| Chieco Bianchi A.M., Museo Nazionale Atestino. Este, Roma 1999. |
| 1902-2002. Il Museo di Este: passato e futuro , a cura di Chieco Bianchi A.M., Ruta Serafini A., Treviso 2002. |
| I Veneti dai bei cavalli , a cura di Malnati L., Gamba M., Treviso 2003. |
| Musei e raccolte archeologiche del Veneto , a cura di Di Mauro A., Dosson di Casier 2004, pp. 53-58. |
| Tagliaferro C., Anelli e gemme del Museo Nazionale Atestino, in Quaderni di Archeologia del Veneto, XXII, 2006, pp. 167-173. |
| Bolla M. , Bronzi figurati romani del Museo Nazionale Atestino, in Aquileia Nostra, LXXIX, 2008, pp. 33 - 120. |
| Bonetto J., Veneto (Archeologia delle Regioni d'Italia), Roma 2009, pp. 401-406. |

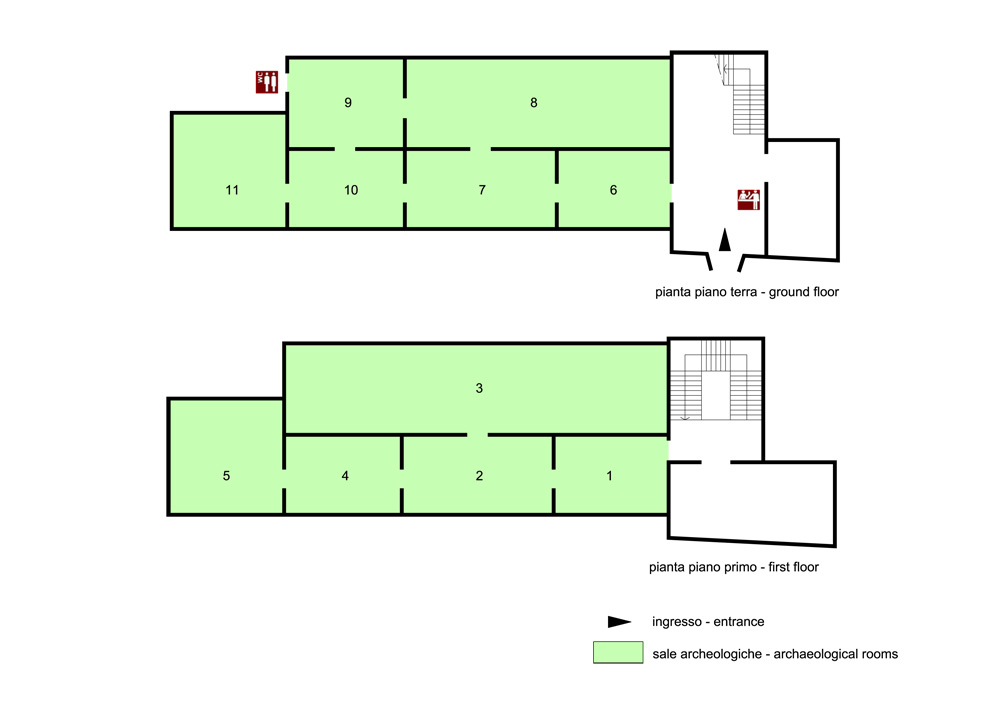
 Accesso per le Scuole
Accesso per le Scuole
 Accessibilità Disabili
Accessibilità Disabili
 Servizi igienici
Servizi igienici Bookshop
Bookshop Punti di sosta
Punti di sosta Guide a stampa
Brochure
Guide a stampa
Brochure Pannellistica
Pannellistica Schede mobili
Schede mobili Didascalie delle opere
Didascalie delle opere Postazioni informatiche
Postazioni informatiche Supporti informativi multilingue: Francese
Tedesco
Inglese
Supporti informativi multilingue: Francese
Tedesco
Inglese Visite guidate
Visite guidate  Attività didattiche
Attività didattiche Laboratorio didattico
Laboratorio didattico Biblioteca/Centro di Documentazione
Biblioteca/Centro di Documentazione Spazi per altre attività
Spazi per altre attività









